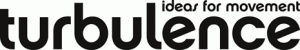Andare verso la luce?
Postscriptum per un 2007 turbolento

E’ notte e un uomo è a carponi sotto a un palo della luce. Cerca le chiavi della sua macchina. Arriva una donna e comincia ad aiutarlo. Dopo avere cercato insieme per qualche istante, la donna chiede all’uomo: “Sei sicuro che ti siano cadute proprio qui?”. L’uomo risponde: “No, mi sa che mi sono cadute da qualche altra parte”. “Allora perché le stai cercando qui?”, domanda la donna. “Perché qui c’è luce”.
All’inizio del 2007, il collettivo Turbulence aveva commissionato 14 articoli dal giro del ‘movimento dei movimenti’, chiedendo agli autori. “cosa significherebbe vincere?” Abbiamo pubblicato le loro risposte in un giornale stampato in 7.000 copie, la maggior parte delle quali sono state distribuite durante la mobilitazione contro il summit del G8 a Heiligendamm, Germania, in giugno. Qualche mese dopo, vogliamo tornare sulla questione della vittoria. Nel momento in cui riprendiamo la nostra ricerca non sorprende imbattersi ancora una volta nel problema della visibilità. Quando pensiamo alla vittoria, i nostri occhi sono attirati da cose molto visibili o facili da misurare, come un cambiamento istituzionale o legislativo, l’apertura di un centro sociale o l’aumento dei partecipanti a una mobilitazione. E’ lì che c’è luce. Ma abbiamo anche bisogno di considerare le vittorie nel mondo delle possibilità, meno tangibile e tuttavia altrettanto reale. Vincere in questo mondo implica l’accrescimento di potenziale, cambiamenti nelle percezioni o negli schemi di comportamento. Ancora, questi aspetti sembrano esistere proprio sul limitare della zona luminosa.
Questo problema ne comporta un altro: le nostre esperienze creano le loro zone di luce e di conseguenza le loro aree di oscurità. Quando pensiamo alla vittoria siamo portati a pensare a movimenti, persone ed eventi che ci sono familiari; e non ci chiediamo come le cose dovrebbero rovesciarsi per costituire una vittoria. Come possiamo superare la nostra cecità notturna una volta che ci spostiamo oltre il conosciuto? In un certo senso questa abilità di guardare al di fuori di noi stessi è stata la chiave di Heiligendamm.
Heiligendamm: una ripetizione differente?
Sotto diversi aspetti, quest’anno il summit dei G8 sulla costa baltica della Germania è stato più di quello che si saremmo aspettati: una ripetizione di precedenti contro-vertici, almeno da Seattle in poi (Praga, Göteborg , Genova, Evian, Cancun, Gleneagles…). Ognuno di questi eventi ha visto una costellazione di attori uniti in una cooperazione produttiva. Ognuno ha creato uno spazio e messo in moto dei processi di contaminazione che erano la chiave per la politicizzazione di una generazione di attivisti. Da un lato, le persone lanciarono delle sfide pratiche alla legittimità del comando globale (il rifiuto del dialogo, il blocco delle strade che portavano alla sede del summit); dall’altro lato, vennero prodotte comunanze e mutazioni nei campi e nei centri di convergenza, durante i dibattiti e le azioni.
Tuttavia, le precedenti mobilitazioni contro i summit avevano già mostrato i limiti di eventi di questo genere. Dopo Seattle, nel 1999, era diventato chiaro che gli effetti prodotti durante le azioni di massa non si trasferivano automaticamente in pratiche quotidiane di trasformazione. Due anni dopo, Göteborg e Genova mostrarono il prezzo pagato da un movimento che entrava nella logica di un conflitto quasi simmetrico (carcerazioni, lesioni e morte). E Gleneagles, nel 2005, mise in chiaro quanto il desiderio di un movimento possa essere catturato e rivolto contro di esso, con 300.000 persone a marciare per il G8. Con queste premesse, l’ultima cosa che potevamo aspettarci era che Heiligendamm potesse essere qualcosa di differente.
Qualche volta quello che sembra essere una mera ripetizione rivela di non esserlo affatto. Quindi, piuttosto che tornare in un particolare punto in un ciclo (“Portare Seattle in Germania”, per esempio), il punto a Heiligendamm era di ricominciare con un divenire imprevedibile, che potesse andare oltre i risultati e i limiti del passato. Non tanto una ripetizione che cercasse di imitare, quanto un nuovo esperimento nella produzione di politica; che fosse un superamento piuttosto che una riaffermazione delle identità esistenti.
Nel periodo precedente il summit, i gruppi coinvolti nell’organizzazione della protesta si sono sottoposti a una sorta di riconfigurazione. Hanno fatto alcuni passi verso il diventare un più genuino “movimento dei movimenti”. Una comune “coreografia della resistenza” è stata progettata e costruita da una grande varietà di gruppi – dalla sinistra radicale autonoma alle persone che organizzavano preghiere collettive interconfessionali contro la povertà. Mentre gli elementi più radicali provavano a stabilire i termini della coalizione (un rifiuto della legittimità dei G8 insieme alla tolleranza per diverse forme di azione), c’era una volontà di compromesso e di arrivare ad accordi comuni riguardo a quali forme di azione fossero appropriate, in quale luogo e quando. In questo modo Heiligendamm andava verso il principio della “diversità delle tattiche” che è diventato di uso comune e tornava ai primi processi di fecondazione reciproca. Invece che impegnare diverse correnti politiche in forme diverse di azione – in uno spirito di solidarietà che non mette in discussione le proprie identità – il lavoro fatto in Germania andava nella direzione di “divenire altro, insieme”. Questo significava progettare e portare avanti collettivamente forme di azione nuove per tutti, azioni e alleanze capaci di portare le persone oltre le loro zone di comfort verso la costituzione pratica di nuovi commons, e quindi verso nuovi, comuni, potenziali.
Qual’è il punteggio?
Mentre Heiligendamm non è stato, quantitativamente parlando, il picco massimo nella storia del movimento contro la globalizzazione (in termini di numeri, Genova e Gleneagles erano stati entrambi quattro volte più grandi), sotto altri punti di vista è sembrato che un nuovo picco qualitativo fosse stato raggiunto. E’ stata una “vittoria” perché è stato un momento di ricostituzione, non da poco per la sinistra tedesca. Ma è mancato qualcosa a questa impressione di vittoria: la sensazione di avere sconfitto l’altro lato. Certo, abbiamo registrato qualche successo contro la polizia e gli organizzatori del summit con i nostri blocchi di massa. Ma la cancelliera tedesca Merkel ha accresciuto la sua legittimità mostrando di costringere i recalcitranti nordamericani ad un accordo sul cambiamento climatico. E il G8? Il summit ad Heiligendamm ha avuto maggior successo di altri summit, perché è riuscito a creare l’impressione che i leader del mondo stiano affrontando la “sfida globale” del cambiamento climatico.
Quando il G8 divenne per la prima volta l’obiettivo di proteste di massa, verso la fine degli anni ‘80, era abbastanza facile puntare contro l’illegittimità intrinseca delle sue attività. Al summit di Colonia nel 1999, quando rispose in modo maldestro alle azioni dei movimenti sociali del Sud globale (e di qualche ONG del Nord) approvando un programma di riduzione del debito, difficilmente qualcuno li prese sul serio. Ma il G8 ha reinventato se stesso. Ha smesso di essere soltanto il luogo in cui i maggiori poteri del capitalismo potessero smussare le differenze per diventare un circo mediatico che si presenta come l’unico forum in grado di gestire i problemi globali. In altre parole, quando il G8 fu messo sotto attacco il suo reale scopo divenne la rilegittimazione della sua autorità globale. E ha imparato bene la lezione. A Gleneagles, una grande operazione delle ONG sponsorizzata dal governo britannico ha visto la partecipazione di 300.000 persone. Non per dimostrare contro il G8, ma per dare il benvenuto a e fare ‘lobby’ per la riduzione del debito e l’aumento degli aiuti per l’Africa.
L’iniziativa persa in Scozia – dove le proteste sono state dirottate da un’efficiente offensiva delle pubbliche relazioni – è stata riguadagnata con successo a Heiligendamm: l’esplicito obiettivo di tutte le azioni maggiori era di delegittimare il G8. Il problema comunque era che il G8 era ancora una volta andato avanti, cercando di guadagnare legittimità con l’operazione di immagine sul cambiamento climatico. E qui è dove noi ci siamo persi e abbiamo perso. Le azioni portate avanti in Germania hanno fallito nel trasmettere una sfida politica alla rilegittimazione del G8 sulla tematica del cambiamento climatico, che è diventato un nuovo terreno di lotta.
Come è potuto accadere? Una ragione è che ancora non esiste una narrazione includente e ‘alternativa’ all’agenda del capitalismo globale, recentemente tinta di verde: per quanto la loro storia possa essere negativa, non c’è niente altro da offrire. Ma il problema va più a fondo di questo. La narrazione del G8 sul cambiamento climatico è una fiction, così come è stata la campagna che doveva consegnare la povertà alla storia passata. Ma non possiamo opporci a questo con un’altra fiction creata da noi stessi: al momento noi non sappiamo come ‘risolvere’ il problema del cambiamento climatico. Nessuno di noi può vedere abbastanza chiaro o guardare abbastanza lontano. Tutto quello che possiamo fare è spostarci da una pozzanghera di luce all’altra.
Cosa c’è’ nel limite? capitale, crisi e cambiamento climatico
Non è una coincidenza che parlare del G8 dovrebbe portare direttamente a parlare del cambiamento climatico. Per i movimenti, esso rappresenta la possibile nuova emergenza di un nuovo centro dell’attenzione. Come mostrato dalle voci che girano nell’opinione pubblica e in eventi come quello del campo sul clima di quest’anno in Gran Bretagna, che sembra sarà ripetuto in Germania, negli Stati Uniti, in Svezia e da altre parti nel corso del 2008. Dalla prospettiva dei governi e del capitale, sta diventando un elemento chiave nella gestione del sistema globale, sia al livello di processi decisionali che di legittimizzazione del potere, per non parlare delle nuove nicchie di mercato. Nello spazio tra i movimenti e i governi, il cambiamento climatico esemplifica l’ambiguità e la complessità della questione della ‘vittoria’. Visto che negli ultimi anni l’attivismo ambientalista si è dedicato ad aumentare la consapevolezza della minaccia del cambiamento climatico, allora il 2007 dovrebbe essere l’anno in cui noi ‘abbiamo vinto’. La tematica è ormai dappertutto e tutti ne parlano, inclusi politici e grandi compagnie.
Ancora, è proprio questa vittoria che potrebbe rivelarsi una sconfitta. La preoccupazione globale per il cambiamento climatico deve assumere una nuova forma se vogliono effettivamente intaccare la situazione attuale (cioè, ridurre drasticamente l’emissione di diossido di carbonio nel breve termine). In parte, questo significa costruire una nuova narrazione che possa fermare la trasformazione di questa tematica in una enorme opportunità di produzione di profitto per il capitale. Senza questo, è facile immaginare che il cambiamento climatico possa essere usato per diffondere un nuovo regime di austerità per i governati e per legittimare l’utilizzo di misure come l’aumento della ‘sicurezza’ e del controllo delle frontiere come aumento delle tensioni geopolitiche. Ma se vogliamo andare al di là della disputa interna all’opinione pubblica – in cui noi siamo sempre in svantaggio – allora la battaglia deve spostarsi al livello della produzione e riproduzione sociale.
E’ comune pensare al cambiamento climatico come un problema tecnico-ambientale che richiede soluzioni tecnico-ambientali: il problema è troppo diossido di carbonio che viene immesso nell’atmosfera, così la soluzione è ridurre queste emissioni a livelli ‘accettabili’ attraverso l’innovazione tecnologica, la legislazione dei governi e le persone comuni che contribuiscono con la loro piccola parte’. La difficoltà qui è doppia. In primo luogo, quasi tutto quello che facciamo è legato al l’uso di combustibili fossili e le risultanti emissioni di CO2: dai viaggi di lavoro al prendere un giorno di malattia per potere vedere un DVD. In secondo luogo, i tagli richiesti (circa il 60-90% prima del 2050) sono così alti da richiedere cambiamenti radicali, e non possono essere risolti semplicemente dall’azione comune dei ministri dell’ambiente di tutto il mondo.
Un modo alternativo per capire il cambiamento climatico è in termine di metabolismo. Il metabolismo della terra, la sua capacità di processare carbone, va ad una velocità minore di quella del metabolismo del capitalismo contemporaneo. L’economia è in rotta di collisione con la biosfera. Stiamo parlando di un limite dell’espansione del capitale e di una possibile crisi di accumulazione.
Per il capitale i limiti sono peculiari. Il capitale ha una dinamica di espansione interna che deve essere soddisfatta, così i limiti possono essere ignorati, sovvertiti, evitati o altrimenti superati. E il segreto della longevità del capitale sta precisamente nella sua abilità di usare i limiti e le crisi che questi generano come una piattaforma di lancio per un nuovo ciclo di accumulazione ed espansione. Un buon esempio di questo dinamismo è l’emergere della cosiddetta fase del capitalismo Keynesiana/Fordista. Gli elevati livelli di organizzazione della classe industriale di lavoratori nella prima metà del ventesimo secolo – non soltanto la Rivoluzione Russa, ma anche le intense lotte in tutto il mondo – sembrarono un limite all’espansione del capitalismo, che minacciavano non soltanto di fermarne l’accumulazione ma di distruggere il sistema una volta e per tutte. Lo stato sociale è stato il risultato diretto di queste lotte, ma è stato anche un modo per neutralizzare questa minaccia. E l’impresa più grande del capitale è stato il patto di produttività che di fatto ha trasformato questo limite nel motore di una nuova fase di crescita del capitalismo.
Cosa ci dice l’analisi delle risposte generiche del capitalismo alle crisi dovute ai suoi limiti a proposito di risposte simili al problema del cambiamento climatico? Non ci sono dubbi che il cambiamento climatico sia un limite che presenta tante opportunità quanti pericoli per il capitale. Molti stanno cogliendo al volo questa occasione per prendere questo nuovo limite, questa crisi potenziale, e trasformarlo in un nuovo motore per l’accumulazione. Si chiede a gran voce il diritto di acquistare e vendere emissioni di carbonio: crediti di carbonio, compensazioni di carbonio, lo scambio di crediti di emissione, contratti a termine e a premio sul carbonio. E poi c’è il consumismo verde: automobili ecologiche, pannelli solari, trasformazioni delle case in abitazioni ecologiche. Il cambiamento climatico potrebbe introdurre un nuovo dinamismo nell’economia globale? Stiamo assistendo a una nuova fase ‘verde’ del capitalismo, in cui l’atmosfera è aperta come era il cyber-spazio degli anni ‘90? E’ possibile. Ed è anche ovvio che non si tratta di ridurre in modo radicale le emissioni di ossido di carbonio!
Una soluzione capitalista avrà lo stesso aspetto, diciamo, del capitalismo stesso. Proprio come gli effetti del cambiamento climatico sono ineguali, poiché hanno un effetto molto più devastante sui poveri – si pensi all’impatto dell’uragano Katrina a New Orleans o a quello dello tsunami dell’Asia dell’est su Aceh. Perciò, quasi tutto l’insieme di soluzioni proposte fino ad oggi contribuiranno anche a rinforzare le gerarchie esistenti. La maggior parte delle tasse “verdi” aumenterà il prezzo dei beni e servizi di base, limitando la mobilità e l’accesso a cibo e riscaldamento. L’accesso ai viaggi, al cibo e alle comodità coincidono con il possesso di denaro? Niente di nuovo, certo: si tratta soltanto delle regole del gioco così come le consociamo. Eccetto che ora saranno giustificate sulla base del fatto che sono necessarie per salvare il pianeta. Ci si deve aspettare che il ‘capitalismo verde’ sia un nuovo regime di austerità e disciplina, imposto ai poveri più che ai ricchi nel nome del ‘bene supremo’.
L’occhio della tempesta
Ma il capitalismo non è invincibile. Se il cambiamento climatico potesse aprire un momento di crisi, allora varrebbe la pena di provare a immaginare le sue dinamiche.
Un aspetto chiave è la variabile del tempo, intesa in due diversi modi. In primo luogo, c’è un problema di sfasamento temporale. Il risultato delle varie decisioni, in termini di cambiamento climatico, sono percepite decine di anni dopo. A causa dell’inerzia termica del sistema climatico, c’è un’enorme discrepanza temporale tra causa ed effetto. Questo significa che le conseguenze del cambiamento climatico diventato ‘incontrollabile’, potrebbero comunque rimanere stabili per diverse decine di anni. In secondo luogo, tutte le prove scientifiche indicano il problema come urgente. Le emissioni devono essere drasticamente ridotte entro i prossimi dieci anni se vogliamo evitare i punti di ribaltamento – punti in cui il cambiamento climatico diventa potenzialmente irreversibile e catastrofico per la maggioranza della popolazione della terra (la morte della foresta Amazzonica ne è un esempio).
In questa sensazione di urgenza c’è un lato positivo. Molto attivismo per ‘aumentare la consapevolezza’ degli ultimi dieci anni ha lavorato senza una qualunque variabile tempo; si è rivolto al ‘pubblico’, un ‘altro’ generico che aveva bisogno di essere ‘informato’ su quello che stava succedendo. Per questo, non c’erano scadenze generali, calendari globali, obiettivi particolari, non c’era la sensazione di escalation. L’urgenza del cambiamento climatico solleva domande importanti soltanto a causa della variabile tempo. Sono domande di strategia e tattica.
E torniamo alla domanda sulla vittoria. Per esempio, qualcuno suggerisce che niente di tanto grande possa essere fatto con così poco tempo a disposizione e il meglio che si possa fare è cominciare a prepararsi al peggio già da ora. Potremmo anche spegnere le luci e gioiosamente buttarci a capofitto nel buio. Altri hanno detto che il problema è così imponente e pressante che soltanto un ente centralizzato è capace di affrontarlo. Di fronte all’abisso dello sconosciuto è allettante tornare indietro verso la luce confortante dello Stato. Ma questa stridente luce abbagliante così come illumina rende anche ciechi.
Si prenda l’esempio dei viaggi via aria. La crescita del traffico aereo è chiaramente un enorme problema ambientale, perciò è facile essere tentati di appoggiare nuove tasse sui voli o anche di considerare le persone che viaggiano come parte del problema. Ma concentrarsi su questa tematica potrebbe rendere più difficile vedere alcune delle altre dinamiche al lavoro. Limitando la nostra autonomia o rafforzando le istituzioni statali e capitaliste, alcune delle soluzioni al cambiamento climatico potrebbero impedire altre lotte e rendere più difficile affrontare le più vaste cause del cambiamento climatico. Quello di cui c’è bisogno è una lente – un approccio o un’etica – che ci permetta di porci la domanda su come le politiche legate al cambiamento climatico possano intrecciarsi con altre lotte. Non perché i movimenti hanno bisogno di una esplicita, cosciente connessione per risonare uno con l’altro. Ma abbiamo bisogno di portare alla luce risonanze e dissonanze. Quando riusciamo a vedere i percorsi, diventa più facile seguirli.
Anche se dobbiamo essere cauti nel diventare ciechi a causa della luce abbagliante dello stato, non possiamo semplicemente chiudere gli occhi di fronte ad esso. Quindi, come possiamo relazionarci alle forme istituzionali? Forse i recenti avvenimenti in America Latina possono darci qualche suggerimento.
Cambiare il mondo prendendo il potere?
Gli ultimi anni hanno visto l’avanzata e l’affermazione di governi con diverse sfumature di rosso da un capo all’atro dell’America Latina. Il Venezuela di Chavez, la Bolivia di Morales e il Brasile di Lula hanno prodotto la maggior parte delle discussioni internazionali. Ma ci sono anche l’Ecuador di Rafael Correa, Tabaré Vasquez in Uruguai, il ritorno di Daniel Ortega in Cile e i Kirchners in Argentina. Questi processi nazionali non sono indipendenti, ma condividono due tematiche correlate: in primo luogo, il modello neo-liberale ha esaurito l’energia nella regione e, in secondo luogo, il movimento dei movimenti è riuscito a lasciare il suo segno a livello istituzionale.
Ma cosa ce ne facciamo di questo successo istituzionale? Qualcuno vede queste vittorie elettorali come il solo, concreto, risultato di questi anni post-Seattle. In questo senso, ‘vincere’ sarebbe anche la sconfitta del ‘movimentismo’ di quel periodo: la conferma che è impossibile ‘cambiare il mondo senza prendere il potere’. Seguendo questa logica, tutto quello che rimane da fare è assicurarsi che, una volta al potere, i partiti e i gruppi che emergono da quella ondata di resistenza siano capaci di produrre cambiamento all’interno dei limiti istituzionali. Inoltre, questi partiti e gruppi che sono andati al potere devono anche essere forzati, dove possibile, a trasformare le istituzioni in modo da renderle più permeabili alla ‘pressione dal basso’. E’ dato per scontato che questa pressione può adempiere al suo dovere soltanto se è capace di tradursi in forme istituzionali.
Anche se non dovremmo sottostimare l’avanzamento che sta avendo luogo in gran parte dell’America Latina, è utile fermarsi a considerare le implicazioni di questa visione del cambiamento sociale.
Prima di tutto, è importante non nascondere alcune differenze importanti tra questi Paesi. Soltanto il caso di Morales corrisponde direttamente all’immagine di una crescente ondata di resistenza che porta a una vittoria elettorale. La storia della Bolivia negli ultimi dieci anni è stata punteggiata da momenti di radicalizzazione che sono stati sempre reinseriti nel sistema politico esistente. Quando gli episodi di resistenza divennero più frequenti e potenti, forzarono il riordinamento sistemico che portò al potere il Movimiento al Socialismo (MAS) di Morales. In Brasile una simile ondata ebbe luogo negli anni ‘80 e fu sconfitta tre volte alle urne prima che Lula venisse eletto. Da allora, il Partito dei Lavoratori (PT) è diventato la traduzione all’interno delle politiche di partito di un movimento in declino (con l’eccezione del Movimento dei Sem Terra). In Venezuela, nonostante una rabbia diffusa nei confronti dell’impermeabilità delle istituzioni e delle politiche implementate negli anni ‘80 e ‘90, non c’era un movimento. Chavez ha agito come catalizzatore per un intensificarsi della mobilitazione e della partecipazione che è sconosciuto nella storia del Venezuela. Rimane da vedere se Chavez era soltanto il catalizzatore o se ora è diventato un pilastro senza il quale tutto potrebbe sgretolarsi.
Più significativamente, l’idea che queste vittorie elettorali siano soltanto il risultato pratico degli ultimi dieci anni è incrinata da due considerazioni correlate. In primo luogo, assume che le ‘politiche’ avvengono solo nelle istituzioni in cui le cerchiamo normalmente. Questo tiene in poco conto un’intera serie di reti, infrastrutture, conoscenze, culture e così via – una diffusa ragnatela di intelligenza collettiva e memoria che è sempre attiva in un modo o nell’altro, che produce cambiamento di continuo e che si cristallizza in una forza antagonista in alcuni momenti cruciali. L’escalation di resistenza in Bolivia prima della vittoria del MAS ne è un buon esempio. Quello che ‘scompare’, dopo ogni punto critico “ritorna” più grande e più forte. E riesce a farlo soltanto perchè non è mai realmente scomparso. In secondo luogo, ignora il fatto che i movimenti, fino a quando continuano a muoversi, hanno un modo di causare e produrre cambiamento che non ha bisogno di passare attraverso, o anche di venire riconosciuto da, le politiche istituzionali. Solo per fare qualche esempio, i movimenti possono produrre cambiamento trasformando il discorso pubblico, rendendo una legislazione inattuabile o semplicemente attraverso il loro potere di auto-governo e di auto-costituzione indipendente.
E se ci fosse un nuovo ciclo di lotte e noi non fossimo invitati?
Questa questione del potere dei movimenti ci riporta al punto da cui siamo partiti. Come si diceva nel giornale Turbulence avevamo tre ragioni per fare una pubblicazione al summit di Heiligendamm. La prima è molto pragmatica: si potrà facilmente raggiungere un pubblico vasto. La seconda è che in tutta la nostra esperienza queste mobilitazioni sono spazi in cui la gente è più aperta a nuove idee. La terza implica una scommessa più complessa. Da Seattle in poi queste mobilitazioni sono state quelle più visibili, il modo in cui la forza e gli orientamenti si possono valutare. Ma al tempo stesso in quelle occasioni appaiono più evidenti i limiti potenziali del movimento.
Su un piano la scommessa era che ognuno si chiedesse: quanto sarà realmente rilevante e trasformativo quell’evento? Sarà un ultimo singulto, un nuovo inizio, o nessuna delle due cose? E come lo capiremo, in ogni caso?
Ma se critichiamo quelli che sanno riconoscere i cambiamenti solo a livello istituzionale, non sarà che i movimentisti sono ugualmente colpevoli di cercare le risposte sempre negli stessi posti? Qui stiamo ancora parlando di proteste e contro-summit. Forse l’impasse degli ultimi anni è nata proprio dal fatto che la gente non ha visto risposte nei posti in cui andava a cercarle, e non ha mai cominciato a cercarle in altri posti. E se ci fosse un nuovo cicli di lotte e noi non fossimo invitati?
Si pensi a quel che è successo nelle banlieues francesi nell’autunno 2005 (e che sembra ritornare mentre stiamo scrivendo). Chiunque nella sinistra – partiti, sindacati, ‘attivisti’; se capisci di chi stiamo parlando, appartieni a questa categoria! – che dichiari che quei ribelli sono ‘con noi’ in senso forte sarebbe colpevole di appropriarsi della lotta altrui rappresentandola in maniera distorta. Certo lottano contro molte cose cui noi ci opponiamo. Ma guardiamo alla reazione della sinistra, lungo tre linee generali. O le banlieues sono entrate in una cornice preconfezionata, e diventano la prova di qualche nuovo livello del capitalismo. Oppure significano il terrore di una dissoluzione sociale che richiede intervento di Stato per ridistribuire ricchezza e accesso alle opportunità nel lungo termine, e magari anche per controllarle nel breve periodo, così da prevenire la guerra civile. Oppure rappresentano un astratto “altro” romantico la cui radicalità dura e senza compromessi – un’immagine da poster sulla rivoluzione – è ricambiata con altrettanta astratta solidarietà.
Se questo è tutto quello che noi – partiti, sindacati, ‘movimentisti’ – abbiamo da offrire, allora riconosciamo che siamo parte del problema. Anche i più radicali della sinistra potrebbero solo interpretare le banlieues come una eruzione di pura negatività, una forza di natura piuttosto che il lavoro di gente reale. Per i politici mainstream, questa è la faccia della paura: siamo al limite della guerra civile! Per altri, non è nulla in sé, ma dato che si tratta di una quantità sconosciuta si può collocarla dovunque nella teoria: ‘Vedi, conferma le nostre previsioni!’ Quest’ultimo caso semplicemente elimina l’evento, qualsiasi cosa sia accaduta vuol dire sempre la stessa cosa. I primi due casi, riconoscono un evento, ma lo vedono come qualcosa che va oltre ogni spiegazione al punto di essere un annuncio della fine del mondo (qualcosa da festeggiare o da deprecare a seconda dei gusti).
Tutte e tre le posizioni ignorano il fatto che se le banlieues pongono un problema, questo è un problema fatto di carne e di ossa. Le banlieues rivelano uno scarto della nostra conoscenza: fin quando non si colma questo vuoto restiamo nel gioco che li esclude. Peggio, ponendoci come interpreti di qualcosa a cui non parliamo, riproduciamo attivamente questo gioco. E c’è da guadagnare politicamente qualcosa anche per i più marginali gruppetti di sinistra, fingendo di parlare a nome di quelli che stanno fuori dalle porte. La sfida vera, allora, sta nell’aprire davvero le porte a quelli che stanno fuori. O meglio, nell’abbattere il muro completamente. Ma questo tipo di coordinamento si può realizzare solo attraverso un lavoro effettivo con la gente vera. C’è poco da guadagnare a fingere che astratti sentimenti di solidarietà servano in qualche maniera.
Un altro esempio: per un anno varie città spagnole hanno visto un movimento unitario crescere in mezzo alla frustrazione della gente per l’impossibilità di avere case decenti di fronte a una speculazione rampante. Il movimenti è iniziato quando, durante le proteste anti-CPE in Francia, un individuo anonimo mandò un email che chiamava a un giorno di protesta per “case decenti”. L’email fece il giro e nel giorno prestabilito centinaia di persone – dai tassisti alle parrucchiere, così come gli ‘attivisti’ – scesero in strada. Nel secondo giorno di protesta autoconvocata c’erano migliaia di persone coinvolte. Da allora si sono create numerose assemblee locali, molte delle quali vanno ancora avanti.
Le reazioni degli ‘attivisti’ a questa lotta sulla casa sono state interessanti. Andavano dalla confusione (‘Come mai c’è una protesta e io non so chi l’ha organizzata?’), al desiderio di scomparire nella scena (‘Nell’assemblea tutti sono uguali, la gente non dovrebbe aspettarsi che noi abbiamo qualcosa di speciale da dire’) a un riconoscimento di come le loro conoscenze specifiche potevano essere utili (‘Bene, una volta ho organizzato una protesta, e capisco che funziona meglio se faccio le cose così’). La gente con meno esperienza politica, dall’altra parte, qualche volta sembrava andare nella direzione opposta: l’assemblea di Madrid a un certo punto discusse se doveva aderire a una protesta che non aveva convocata. – Adesso siamo lo spazio in cui il movimento si organizza, dovremmo essere gli unici a decidere queste cose’. ‘Ma come? Non era tutto cominciato con una dimostrazione spontanea? A quella tu c’eri? C’ero, ma questo è accaduto prima che ci fosse l’assemblea!…’
Tutto questo sottolinea il fatto che, quale che sia il significato che diamo all’etichetta “movimento dei movimenti”, non offre nessuna garanzia. ‘Seattle’ o ‘Cancun’ o ‘Heiligendamm’ non significa che ‘noi’ siamo l’alfa e l’omega del cambiamento sociale. In effetti non significa neppure che ‘noi’ esistiamo. E fingere che esistiamo e che fare la storia sia esclusivamente il nostro compito può solo renderci ciechi al luogo in cui ci troviamo. (E se ci troviamo in un luogo determinato, vuol dire logicamente che non siamo il tutto.)
Verso la luce?
Questo ‘percorso di pensiero’ che abbiamo cercato di tracciare – da Heigilendamm all’America Latina, dalle politiche del cambio climatico alle banlieues, dal ‘movimento dei movimenti’ e ritorno – ci ha visto partire con una domanda e alcune migliaia di giornali da distribuire, e attraversare alcuni temi e problemi che non si risolvono.
Abbiamo iniziato con il tema della visibilità perché questo sottolinea la relazione tra i movimenti e la loro dinamica di auto-riproduzione. E’ relativamente facile pensare ai movimenti che si aggrappano alle politiche istituzionali, come gli esperimenti elettorali in America Latina, o il processo del social forum, o i recenti tentativi di riorganizzare centri sociali in Europa. A seconda della vostra prospettiva, sono esempi di movimenti che ‘si vendono’, o che ‘crescono’ o che ‘sono recuperati’. Ma tutte e tre queste posizioni fanno l’errore di vedere le forme istituzionali come qualcosa di separato dai movimenti. O, mettendola in un altro modo, tutti e tre vedono i movimenti come corpi discreti, con un interno e un esterno, piuttosto che come un continuo spostamento delle relazioni sociali.
Dato che i movimenti si muovono, creano continuamente nuove forme di organizzazione e di pratica che continuamente si insediano e si consolidato. Naturalmente questo può essere problematico: una volta stabilite, le identità e i rituali possono diventare ostacoli al cambiamento. Ma questo non significa che i movimenti muoiano appena prendono radice, o appena si muovono nella luce della visibilità. Questo processo è anche il modo in cui i movimenti proiettano la loro propria luce. Il ‘movimento dei movimenti’ per esempio è una istituzionalizzazione di un certo momento delle lotte, con Seattle come uno dei suoi momenti salienti. Esso ha anche aiutato a generare una serie di altre istituzioni, che hanno sviluppato le loro dinamiche. Le proteste ai summit, per esempio, hanno avuto luogo in tutto il mondo, crescendo una sull’altra con modificazioni sottili e neanche tanto sottili. Quando quel ciclo di proteste è sembrato svanire, è iniziato il processo del social forum, che ha costruito un diverso tipo di esperimento. Dopo il Social Forum Mondiale del 2007 in Kenya, sponsorizzato e controllato pesantemente dalle ONG, molti hanno sentito che anche quel processo è finito. Ma pochi mesi più tardi il social forum degli USA ha mostrato che è possibile organizzare qualcosa capace di durare non solo pochi giorni e di produrre effetti di fecondazione reciproca e di coordinamento di lotte.
I recenti incontri ospitati dagli zapatisti hanno riportato energicamente questo punto. Offrivano un incontro tra, da un lato, visioni di autonomia, orizzontalismo e pratica non gerarchica e, dall’altro lato, un vero tentativo di far funzionare sul campo quelle visioni – sotto la minaccia di un attacco da parte dei paramilitari e circondati da forze ostili. Molti ‘movimentisti’ hanno avuto un contatto diretto con il funzionamento delle ‘Giunte del Buon Governo’, un esperimento a lungo termine di autogoverno dei comuni autonomi zapatisti. Un aspetto sorprendente di questo tipo di esperienza consisteva nell’essere in uno spazio in cui c’erano uomini armati – l’EZLN – che stavano dalla tua parte. Ma se vogliamo seriamente produrre mutamenti in forme visibili e tangibili, come è possibile farlo senza creare istituzioni di un tipo o di un altro? Come altrimenti possiamo creare veramente altri mondi?
Ma c’è un secondo tema di luce e luminosità. Quando ponemmo la domanda “cosa significa vincere?” non chiedevamo deliberatamente un programma in dieci punti. Non volevamo un’illuminazione. Piuttosto, volevamo affermare una politica che riconosca che nessuno ha la soluzione, e cambiare il mondo è almeno in parte un processo di ricerca condivisa, e che come primo passo possiamo cominciare ponendo quelle stesse domande. Questo è un mondo diverso da quello delle politiche della certezza della vecchia scuola, un mondo dominato da scontri polemici in cui le identità differenti si scontrano una con l’altra, ricreando nicchie ideologiche o identitarie.
L’idea di una illuminazione totale è naturalmente una fantasia. Ma è un’illusione molto tentatrice, legata al mito della conoscenza totale. Se guardi il sole per un periodo abbastanza lungo, dietro le tue palpebre rimarrà impressa una immagine residua. Quando il G8 si è impadronito de la questione del cambio climatico alcuni hanno concluso che noi abbiamo semplicemente bisogno della giusta narrazione, di quelle che mostri che soltanto noi abbiamo ‘la risposta’. Piuttosto che adottare questo approccio, con tutti i suoi toni di contropotere e di contro-egemonia, sembra più produttivo imparare un’altra lezione da Heiligendamm. Mentre la gente si preparava a bloccare le strade che portavano al summit, circolò un ultimo avvertimento: “Quando ti avvicini alle linee di polizia, non guardare verso i poliziotti, guardate ai vuoti che ci sono tra di loro.”
Per finire, c’è un terzo filo che lega insieme l’idea di luce e di visibilità. Attraverso questo testo abbiamo usato l’idea di ‘andare verso la luce’ nel senso di rendersi visibili, venir fuori e occupare uno spazio. Ma questo ha un senso diverso nelle cosiddette esperienze prossime alla morte: vedi una luce, e una voce ti invita a muoverti verso la luce. In una certa misura cambiare significa morire. Significa abbandonare la zona di comfort, rinunciare a una parte di te stesso, abbandonare abitudini e certezze. E in un senso più ampio, i movimenti hanno bisogno di flirtare con la propria morte, con la possibilità di dover cessare così che qualcosa di altro possa nascere. Oseremo rischiare questa scommessa? Oseremo compiere questo salto? Oseremo saltare oltre questi vuoti, nell’ignoto, nella luce?
Dicembre 2007
Translated by Alice Mattoni
Translations: English, German, Portuguese and Spanish.